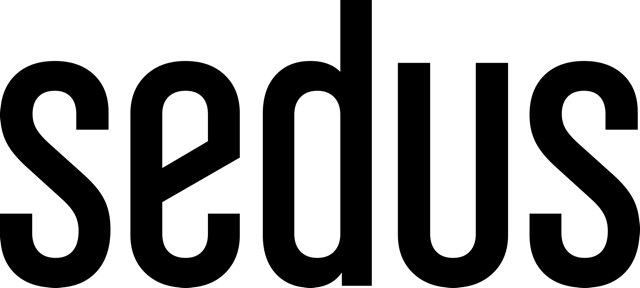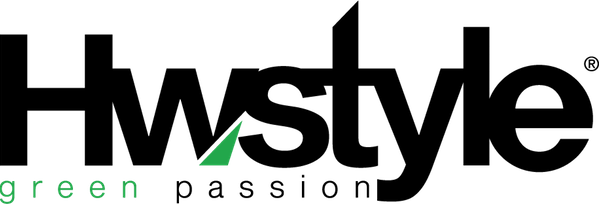Una Biennale dell’impegno sociale, quella di Alejandro Aravena. Senza wow! effect né archistar, senza sconfinamenti nell’arte né visioni ipertecnologiche.
Reporting from the Front non mostra l’architettura bella e innovativa pubblicata nelle riviste, propone un punto di vista attento alle architetture povere delle periferie, fatte di materiali di recupero, di manodopera non qualificata, di creatività che nasce dalla miseria. Una rigorosa visione del “politicamente corretto” in tutte le sue sfaccettature dalla quale traspare però in alcuni casi una sorta di tediosa retorica.
La sala introduttiva della 15 esima Biennale Internazionale di Architettura, Reporting from the Front, all’Arsenale è una vera dichiarazione di intenti. Realizzata riutilizzando 100 tonnellate di materiale di scarto – 10.000 mq di cartongesso e 14 km di montanti metallici- provenienti dallo smantellamento dell’edizione 2015 della Biennale Arte, rappresenta la sintesi del futuro dell’architettura secondo Aravena e il primo tra i nuovi imperativi per l’architetto: no allo spreco.
La sostenibilità è un imperativo, questa non è una novità. L’evidenza interessante in questa Biennale è che la sostenibilità è una necessità per chi non ha mezzi, è uno strumento per la sopravvivenza. Forse è semplicemente buon senso, come sottolinea Transsolar e si attua assecondando la natura anziché contrastandola; ma soprattutto l’architettura sostenibile non deve solo apportare meno danni, ma portare più benefici, come spiega Michael Braungert.
L’uso dei materiali grezzi, di scarto e poveri è l’elemento unificante dei progetti e degli allestimenti: pallets, tubi innocenti, reti per letti, cartone, bambu, stracci e lamiere arrugginite sono il supporto per mostrare lavori e sperimentazioni che cercano, attraverso l’architettura, di dare risposte o tentano di contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente costruito – e della vita- anche in quel “Fronte” dominato da segregazione, traffico, inquinamento, migrazioni, calamità naturali, disuguaglianza.
La sfida è dare una dimensione estetica alla bruttezza, rendere poetica la povertà dell’ambiente costruito, come già era riuscita fare l’arte povera negli anni ’60, generare emozioni e relazioni positive nei luoghi dei diseredati.
I progettisti prendono alla lettera le parole chiave identificate da curatore e le problematiche da affrontare, abbandonano i punti di riferimento canonici dell’architettura e dell’urbanistica. La città perde la sua connotazione di permanenza, si ispira a modelli nomadici, i luoghi di vita assumono una connotazione effimera. Un’accezione di effimero diametralmente opposta a quella che ha ispirato il periodo dell’architettura post-moderna, dello spreco e della superficialità.
La dimensione effimera che arriva dal “Fronte” è un requisito base per una progettazione sostenibile, resiliente, non finita, capace di adattarsi e modificarsi sulla base dei bisogni delle persone.
Significativi da questo punto di vista sono la scuola galleggiante “Waterfront” di Kunlè Adeyemi in Nigeria (ricostruita alle Gaggiandre e vincitrice del Leone d’Argento) per rispondere alla carenza di infrastrutture e ai cambiamenti climatici in stuazione di rapida urbanizzazione;
il Padiglione Spagna “Unfinished”, vincitore del Leone d’Oro, che illustra edifici mai finiti a causa della crisi economica e interventi di recupero a basso costo di edifici esistenti;
la ricerca di Rahul Mehrota all’Arsenale dedicata all’insediamento effimero per la festa religiosa di Kumbh Mela che si svolge ogni 12 anni in India e ospita fino a 7 milioni di persone contemporaneamente.
L’impianto urbanistico, le infrastrutture le tecniche costruttive, la scelta dei materiali l’equilibrio tra edificazione individuale e collettiva, tra spontaneità e coordinamento rappresentano un modello di riferimento per una nuova visione di “metropoli impermanente”, adatta ai costanti flussi migratori e sostenibile: con la pioggia del primo monsone il fiume distrugge l’intero insediamento (realizzato con solo cinque materiali eco-compatibili) senza lasciare alcuna traccia.
Una lezione di umiltà, che l’architettura deve imparare.