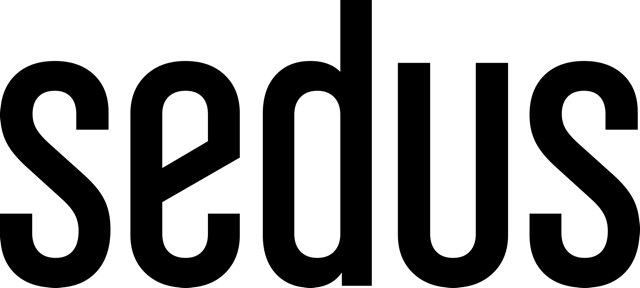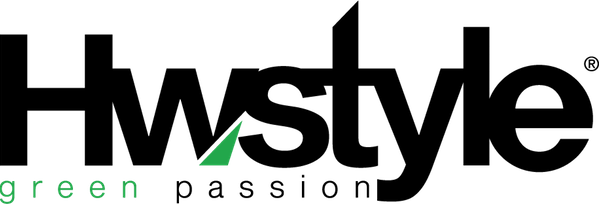Uno spazio di 4100 metri quadri, nuovo di zecca e pensato per trasmettere una grande energia… rimasto improvvisamente vuoto. Nella nostra rassegna di articoli su come gli sono stati ripensati gli spazi di lavoro durante la pandemia, Betty Pagnin, P&C Director di One Day Group, ci parla dell’esperienza del C30, l’headquarter di una delle holding più giovani e dinamiche del panorama milanese, e della necessità di una nuova figura professionale: l’intrattenitore digitale.
L’headquarter C-30 di OneDay Group a Milano, inaugurato nel febbraio 2020 per affrontare l’esigenza di un team e di un “business & Community builder” in grande crescita, rispetta tutti i migliori dettami dell’office design e della progettazione pre-covid: un campus, creato dagli stessi dipendenti del team ad immagine e somiglianza dei loro sogni e della cultura aziendale. Come ha reagito questo spazio e l’organizzazione che lo abita all’improvvisa emergenza corona virus? Ci risponde in questa intervista Betty Pagnin, People and Culture Director di One Day Group.
Come è nato il progetto originario del C30 sviluppato prima del 2020?
“Ci siamo affidati ad un professionista che ci ha aiutato a suddividere le diverse aree, ma, per il contenuto, abbiamo scelto di coinvolgere tutto il team, chiedendo a tutti i dipendenti come si immaginavano l’ufficio dei sogni e quali temi all’interno del spazio si aspettano di incontrare. In seguito, abbiamo coinvolto il team creativo interno, per trasformare le idee in realtà come arredi, sfondi e pareti personalizzate.
Ad esempio il design dell’intero piano “Sottosopra” è dedicato alle passioni dei membri del nostro team: ci sono aree sport, freestyle, murales, un mini zoo club totalmente dedicata ai bambini, una agorà e una sala strategica con un tavolo immenso con disegnata una enorme mappa di Risiko. Il resto dell’ufficio è, poi, dedicato al viaggio, e ogni sala è firmata da qualcuno del team, per favorire l’empatia dei dipendenti con l’ufficio stesso. Abbiamo anche una foresteria, con stanze dedicate ciascuna ad una generazione: anni 20, anni 60, 80, 90 e all’interno avevamo creato anche un cineforum e una libreria”.
Come è stato vissuto il workplace durante la pandemia?
Questo è uno spazio che ti dà un’energia pazzesca nella misura in cui hai 300 persone presenti e con diversi eventi. Il centro è l’area caffetteria all’ingresso, un crocevia di nuove generazioni, il cuore pulsante di questo campus. Un luogo di incontro, dunque. In alcuni momenti, devo dire, che nel vuoto si sentiva l’eco della solitudine: la community fa parte del nostro del DNA, mancava quindi quella vibrazione che si percepisce.
In questo momento, lo spazio è tornato frequentabile, nel rispetto delle nuove condizioni. Per fortuna è molto grande (4100 metri quadrati) perché nasceva per essere uno spazio dove ognuno potesse muoversi liberamente. Alla fine questo ti permette di poter frequentare lo spazio, abbastanza liberamente e utilizzando dei dispositivi di protezione individuale, come la mascherina. Al di là della pandemia, era un workplace progettato per essere uno spazio moderno, non avrà bisogno di rivoluzioni.
Come vi siete adattati alla realtà della pandemia? Quali sono stati i punti di forza e quelli più critici?
In generale, il nostro maggiore punto di forza è stato la comunicazione interna: comunicare il più possibile e nel modo più trasparente possibile, a tutto il gruppo di lavoro e alle communities afferenti, in un momento in cui tutti erano chiusi nelle nostre case.
Essendo abituati a trattare la materia del crisis management, siamo stati pronti e reattivi. Abbiamo lavorato per trasformare tutti i documenti nel cloud e, anche quando si poteva tornare in ufficio, abbiamo puntato sul concedere la massima libertà di decisione e con la massima trasparenza. L’obiettivo era che tutti si sentissero al sicuro e performanti.
Dall’altra parte, invece, le difficoltà sono derivate dal fatto che la nostra community si basa molto su aspetti di interazione e unione fisica. Per quanto noi fossimo organizzati per una certa percentuale di lavoro in remoto, il full remote non era paventato. Ci abbiamo messo un po’ a livello di leadership a trovare un nuovo ritmo. Inoltre, un’ulteriore difficoltà dipendeva dal fatto che il nostro core business ha avuto un colpo grosso: rispetto ad altri business, ci siamo dovuti reinventare il lavoro.
Qual è stata un’esperienza significativa di questi ways of working ibridi?
A Natale abbiamo fatto una merenda per farci gli auguri: la metà del team era presente fisicamente, l’altra metà era in remoto. Un’esperienza che non è banale, perché il team vive contemporaneamente due esperienze diverse. Il debrief è che si può migliorare: è mancata, soprattutto, l’interazione, perché sostanzialmente è mancato uno spazio di condivisione, nonostante ci fosse un addetto con la telecamera con il compito di cercare di far vivere in prima persona l’evento a chi era in remoto. Credo che il lavoro ibrido porti alla necessità di una nuova integrazione, e all’emergere di nuove figure professionali come una persona interamente dedicata a gestire questa interazione, una sorta di “intrattenitore digitale”. Non un compito banalissimo, soprattutto in questo tipo di eventi.
Testo di Gabriele Masi.
Foto e video per cortesia di OneDay Group.