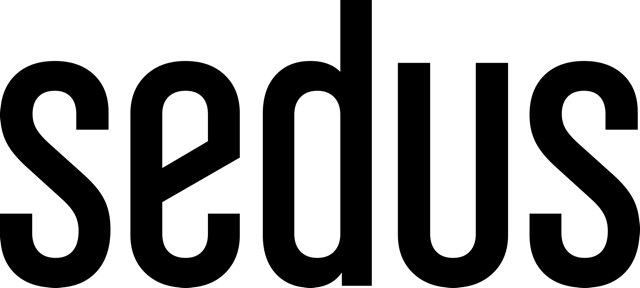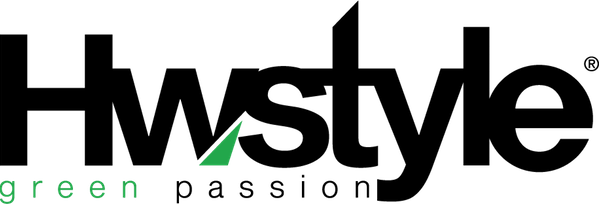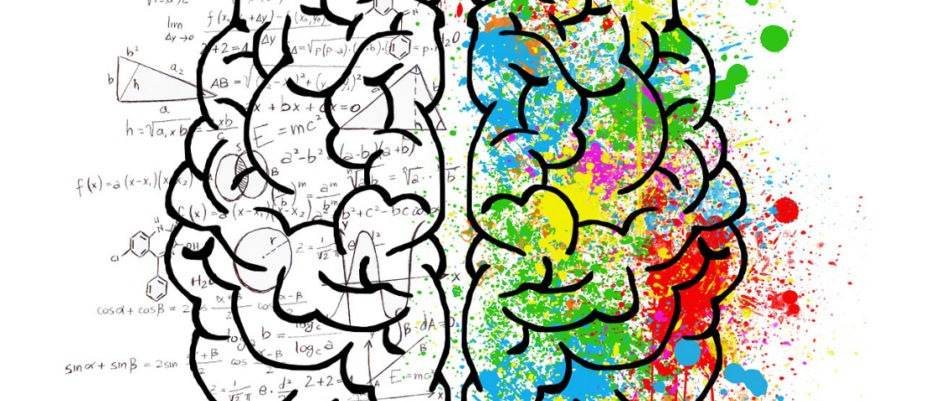
“Non esiste un colore adatto o inadatto, esiste un colore in un contesto. Quando parliamo di colore dobbiamo considerare da una parte il lato quantitativo degli strumenti, dall’altra quello umanistico non quantificabile: è questo il cuore dell’intervento di Aldo Bottoli, fondatore di B&B Color Design e memento del consiglio di presidenza dell’Associazione Italiana Colore, alla conferenza “Il colore nelle Neuroscienze” organizzata da Moroso nel suo showroom milanese con Sarah Robinson.
“Esiste un prima e un dopo l’occhio: fuori da me esiste la materia ed è misurabile, dentro di me esiste esperienza e non è misurabile”. Le neuroscienze, come ha testimoniato l’intervento di Aldo Bottoli alla prima delle tre conferenze “I tre corpi del colore: ispirazioni e visioni”, organizzata da Moroso presso il suo showroom a Milano, forniscono oggi ai progettisti tantissimi strumenti e conoscenze per ripensare l’utilizzo del colore e di molti altri elementi nello spazio. Partendo dalla domanda “come declinare la variabilità cromatica in ufficio?”, il fondatore di B&B Color Design, mediando tra le nuove scoperte neuroscienze e le proprie esperienze sul campo, ha fornito alcune interessanti indicazioni.

Qual è l’obiettivo del progetto oggi?
Il nostro obiettivo è creare un ambiente che risponda sia ad una percezione istintuale sia ad una percezione cognitiva ed emozionale. Dobbiamo capire che cosa parla a tutti e che cosa parla a qualcuno.
Il tema del progetto è qualcosa che deve sapere misurare la materia, ma anche dare consistenza all’esperienza e al fatto culturale. Il progetto di architettura deve essere in grado di fare la rivoluzione copernicana: mettere al centro l’uomo, guardare che gesti fa e in base a questo costruisce l’intorno.
La questione del colore nelle neuroscienze è molto legata alla questione della percezione.
Ogni più piccolo dei nostri comportamenti deriva dall’ambiente naturale, perciò dobbiamo considerare l’ambiente naturale come il modello da cui partire: dobbiamo ricreare quella variabilità che è la ricchezza informativa della natura: temperatura, suono, profumi, luminosità. Nell’artificiale per arrivare al benessere dobbiamo perseguire la variabilità.
D’altra parte, l’uomo vive in un ambiente nel quale opera secondo un sistema visivo-percettivo perfezionato dai nostri predecessori che abitavano in un’immersione totale nell’ambiente naturale.
Noi percepiamo il mondo in parallelo e sinestetico: tutti i sensi collaborano per portare una informazione, il nostro occhio palpa le superfici e ne ricava una informazione tattile. Il colore si tocca: è morbido, ruvido, duro, gustoso e profumato, dolce, poco appetitoso, disgustoso.

Senza dimenticare il ruolo della cultura, del contesto e del vissuto personale…
Il rosso è bello? Per dirlo, deve essere ospitato dentro una scena, non posso parlarne in modo astratto, perché direi solo ciò che ho vissuto. Il vissuto personale è pesantissimo, se devo progettare uno spazio per tante persone, devo lavorare sulla variabilità che esiste in natura, togliere la variante del ricordo personale che un colore dominante scatena e lavorare sulla materia. Bisogna inserire quella che nel mondo della profumeria si chiama “nota olfattiva marziana”: quella fragranza che non si può incontrare nella vita sociale normale, e quindi non ci può far nascere dei ricordi che scatenano una risposta emotiva.
Quindi come la nostra natura e cultura influenzano la percezione del colore?
“Viviamo dentro due contingenze: quella naturale e quella culturale. Il fenomeno del colore è complesso perché le attraversa entrambe. Si tratta di affrontare un fenomeno trasversale che ha le sue radici nella caratteristica fisico-chimica dei fotoni e della materia, ma il significato che esprime lo fa attraverso le forme culturali.
Dobbiamo sempre tenere presente la differenza tra visto e percepito, valutazione estetica antica e considerazione contingente e contemporanea. La moda pesa, ma vi sono dei colori stabili che sottostanno a delle morali antiche che derivano dallo sviluppo della nostra cultura occidentale.
In generale, domina il significato non la lunghezza d’onda: diciamo “vino bianco”, anche se non è bianco o la “legna verde”, anche se non è verde. Nel nostro modo di identificare il colore non c’è mai una corrispondenza esatta dello spettrofotometro.
Testo di Gabriele Masi.