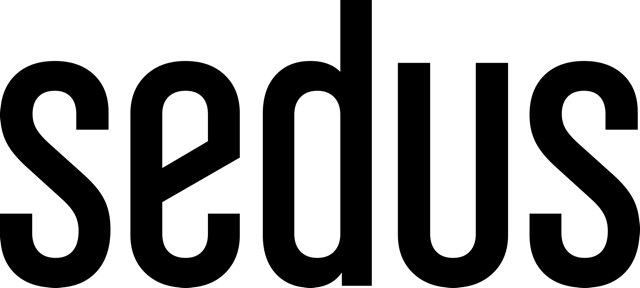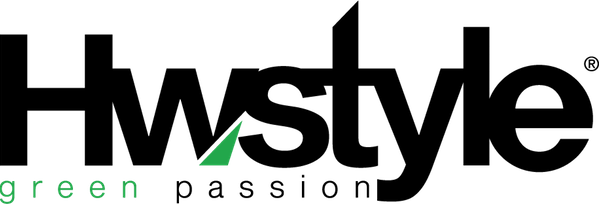Dalla “schiscetta” al bistrot: la pausa pranzo ha subito una sostanziale evoluzione immagine di quella che contemporaneamente avveniva negli ambienti di lavoro e nei ways of working. Dall’isolamento alla convivialità e all’apertura verso la città, da una falla nel sistema scientifico tayloristico ad un momento centrale del lavoro agile, chiave del benessere produttivo ricercato dalle aziende, e in grado, persino, di modificare le abitudini dei dipendenti, erodendo, in modo particolare e inaspettato, i confini esterno-interno, lavoro-privato, singolo-collettività.
Erede di un’ottica tayloristica, la ormai vecchia mensa era quel luogo dove il lavoratore doveva recarsi per consumare la propria pausa pranzo, un intervallo di tempo di necessaria improduttività nell’orologio scientifico dell’organizzazione del lavoro.
Già allora, è vero, si aveva la scelta tra il menu proposto dalla mensa aziendale, il prepararsi un piatto da pronto da casa (la famosa “schischetta”), a seconda dei propri gusti e necessità di dieta, oppure sfruttare diversi ticket o voucher per godere dei servizi di ristorazione offerti dalla città: tutto ciò, però, si portava dietro un’idea di pausa dal resto della giornata lavorativa intesa come una momentanea fuga, un interruttore che si spegneva e che doveva essere riacceso, spesso a malavoglia, dopo un’ora.
(A sinistra Bistrot del Campus Lavazza; a destra il Vive Café dell’Ospedale di Chivasso)
Il primo passo per superare questa vecchia concezione è avvenuto grazie alla sempre maggiore attenzione che viene posta verso un design degli ambienti di lavoro che mettesse al centro la bellezza e la funzionalità degli spazi. Questo trend ha coinvolto inevitabilmente anche le vecchie mense trasformandole in ristoranti e caffetterie aziendali, luoghi belli e accoglienti in cui le persone erano spinte ad intrattenersi ben oltre il rituale “stop and go” del primo pomeriggio, ma anche in altri momenti della giornata: colazioni, pause caffè, o anche fine giornata, facendosi preparare una “schiscetta al contrario” per la cena da consumare a casa. Esempi di questa evoluzione estetica sono il ristorante Bistrot progettato da Cino Zucchi per il Campus Lavazza o il Vive Café di Sodexo presso l’ospedale di Chivasso.
Intanto, si affiancava parallelamente l’idea che la produttività non derivasse da una organizzazione scientifica e rigida del lavoro, ma piuttosto dal suo contrario: dalla flessibilità, dal benessere, dalla possibilità di ogni dipendente di plasmare l’ambiente di lavoro secondo le sue necessità. Inoltre, grazie alla tecnologia, la flessibilità iniziava a sforare i confini dell’ufficio attraverso il telelavoro prima, e il lavoro agile o smartworking poi.
(A sinistra una ricetta CucinaBarilla; a destra il ristorante della sede Sky a Milano)
Mentre il nomadismo della “zainocrazia” portava alla necessità di trovare soluzioni rapide e innovative come CucinaBarilla, l’ufficio aveva bisogno di diventare la “casa” a cui tornare, il centro di gravità di ways of working che sfondavano barriere e partizioni, democratizzando l’utilizzo del tempo e dello spazio, e in parallelo, una casa in grado di prendersi cura della salute e delle esigenze dei propri “inquilini”.
Da momento di necessaria interruzione, la pausa pranzo ha perso, così, la sua unicità, frantumandosi in diversi momenti fecondi di incontro e scambio di idee, così come lo spazio del ristorante aziendale è diventato luogo di accoglienza, meeting informali, conference call, spazio di formazione e location di eventi.
La dimensione fondamentale dell’incontro, resa visibile e concreta nella materialità del pasto, ha spesso, dunque, moltiplicato i luoghi dedicati al cibo in azienda, affiancando il ristorante ad aree break attrezzate: da momento separato, la pausa dedicata al cibo diventa momento diffuso e strettamente e necessariamente legato a ciò che gli sta intorno. Ne sono una testimonianza la sede Sky di Milano, la sede italiana di Plantronics a Vimercate o le isole multifunzione COffice di Estel.
(A sinistra la break area della sede Plantronics; a destra un esempio di isola multifunzionale COffice)
Questi esempi testimoniano anche come la tecnologia sia stato l’elemento chiave di una rivoluzione 3.0 della ristorazione aziendale, rendendo gli ambienti più smart nella gestione di flussi più dilatati nel tempo e più complessi, nella logistica, nella prenotazione nei menu. Ed è proprio ultimi, sempre più gourmet, biologici, a kilometro zero, sani e bilanciati, che notiamo un ulteriore cambiamento radicale.
Se forse la frase “Siamo quello che mangiamo” risulta oggi un po’ troppo assoluta, è vero che ciò che mangiamo contribuisce in modo determinante al nostro benessere. Come hanno testimoniato progetti come la sede Technogym, l’azienda ha messo al centro delle problematiche legate alla propria produttività anche ciò che i propri dipendenti mangiano. Ciò ha portato a spingere anche i dipendenti più ostinati e, a volte parsimoniosi, a fare i conti con la propria “schiscetta” e a modificarla: ciò che si mangia in ufficio è finito così per influenzare ciò che mangiamo a casa.
(A sinistra il ristorante della sede Technogym; a destra la Microsoft House di Milano)
Ed è proprio questo “uscire dai confini” che caratterizza l’ultima grande evoluzione della pausa pranzo: l’apertura verso l’esterno. I business park hanno iniziato ad assomigliare sempre più a campus universitari e i ristoranti e i bar aziendali hanno iniziato ad aprirsi verso l’esterno, diventando strumento preferito di attrazione centripeta del tessuto urbano.
Persino al piano terra di uno spazio dove il ristorante aziendale è “scomparso”, come la Microsoft House a Milano, è presente una libreria e una caffetteria che fanno dell’ufficio non più una partizione esclusiva di un segmento di città, ma una agorà, trasparente come le vetrate delle sue architetture, dove il flusso di lavoro viaggia ininterrotto e senza soluzione di continuità tra esterno e interno. Il cibo diventa così uno dei nodi principali di quella rete di relazioni sempre più estesa e non definibile da uno spazio fisico che è il mondo del lavoro di oggi, e non stupisce in un ambiente dove l’appagamento e il benessere diventano la chiave per portare nell’azienda nuovi talenti, nuove idee, nuove user experiences, come il cibo stesso sia diventato un elemento attrattivo di grande importanza su cui diverse aziende stanno puntando.
(Lounge Lufthansa, Milano Malpensa)
Forse gli ambienti di lavoro diventeranno presto come la Lounge Lufthansa di Milano Malpensa: luoghi di una perenne partenza e ritorno, dove la costruzione dell’esperienza sensoriale diventa la base per la gestione della caotica dinamicità, dove il senso di appartenenza si costruisce mangiando, allegoricamente e al contempo materialmente, una parte dell’azienda. Oppure portandola con noi nei nostri lunghi viaggi non più solo sotto forma di mail o account aziendali virtuali, ma sotto forma di un pocket lunch che segue un percorso molto diverso da quello a cui eravamo abituati e che ci fa a volte dubitare di sapere davvero quale sia effettivamente la nostra vera casa.
Testo di Gabriele Masi.